Che confusione.
Confusi sono piuttosto i miei pensieri dopo letture, appunti, conferenze e mostre. Forse dovrei prendere alla lettera quanto ha dichiarato Maurizio Cattelan in una recente intervista a Oliviero Toscani «è solo quando non penso che affiorano le immagini migliori»: insomma bisognerebbe fotografare senza pensare a quello che si sta facendo perché, a pensarci troppo, quella fotografia rischia di diventare qualcos’altro. Probabilmente un quadro.
La questione che mi inquieta è proprio il rapporto, di corteggiamento e di conflitto, tra fotografia e arte che sembra esaurirsi, fin dai tempi della nascita della fotografia stessa, solo nei riguardi della pittura; più d’uno sono i rimandi che legano questi due media, dalla provenienza dei primi fotografi – spesso dichiarati pittori falliti – alla natura bidimensionale racchiusa all’interno di una cornice materiale e concettuale. Ai giorni nostri non è tanto la prospettiva albertiana, ampiamente superata in pittura fin dalle prime Avanguardie, a tracciare continui rimandi alla pittura, quanto la schiavitù della fotografia nei confronti di quel rettangolo costituito dal passepartout e dalla cornice che ne fanno un… quadro nel senso comune del termine.
Spendo subito il mio bonus stupidità e dichiaro che, se un parallelismo con un altro medium artistico deve per forza esserci, allora questo potrebbe essere con la scultura. Ma ci arriverò, alla fine.
Sono di ritorno da una nuova visita alla Mostra “Sembra un quadro, sembra una foto” che oggi – alla Galleria Sagittaria di Pordenone – vedeva la presenza e le piacevoli spiegazioni dei curatori Guido Cecere e Angelo Bertani.

Come è stato fatto notare, le ibridazioni tra i due mezzi espressivi, pittura e fotografia, sorgono con la nascita di quest’ultima e sono praticamente inscindibili. Ma sempre, più che gli interventi manuali (col pennello) o tecnologici (la più attuale postproduzione elettronica), ciò che maggiormente traspare è il rapporto di sudditanza imposto dalla più nobile pittura e l’inconsapevole complesso di inferiorità sofferto dalla figliastra fotografia. Bene lo ha descritto Michele Smargiassi in una sua metaforica recensione a questa stessa mostra, il quale tra l’altro ne presenterà il catalogo nell’ambito di Pordenonelegge.
Io credo che in qualsiasi processo creativo sia naturale, in alcuni casi, inserire rimandi, riferimenti e citazioni ad altre opere precedenti, ciò serve a dimostrare un atteggiamento colto rispetto a quanto si sta realizzando: questa volontà è evidente anche in musica, in letteratura e nel cinema; ma in molti casi penso che tale rispecchiamento sia addirittura involontario perché determinate immagini, appartenenti in genere alla storia dell’arte, sono talmente sedimentate nel nostro cervello che emergono inconsapevolmente, soprattutto quando si intende dare un valore, persino un tono epico, quando cioè si cerca di dare un senso a qualcosa che si presume entrerà a far parte della Storia.
Quando Joe Rosenthal intese ripetere la foto del momento in cui i soldati issavano la bandiera americana sulla vetta dell’isola di Iwo Jima (consiglio il film che parla di quella celebre battaglia, Lettere da Iwo Jima, per la regia di Clint Eastwood) era consapevole che l’immagine originaria non aveva un sufficiente potere celebrativo (la bandiera era troppo piccola e la composizione non era equilibrata) per quella importante vittoria.

Per scattare quella celebre (seconda) foto realizzò una perfetta messa in scena: mise in posa i soldati e attese il giusto soffio di vento a gonfiare il drappo e realizzò una serie di scatti da cui scegliere quello che sarebbe passato alla storia. Evidentemente Rosenthal cercava di realizzare l’immagine che aveva in mente, come si usa dire: però probabilmente non si rendeva conto che quell’immagine ce l’aveva in mente in senso letterale, “racchiusa nei cassetti” della sua memoria, archiviata tra le migliaia di immagini che un fotografo del suo calibro avrebbe dovuto sicuramente conoscere, altrettanto celebrativa e tanto romantica da divenire epica anch’essa.
La Composizione. Ecco la parola che Claudio Marra individua come discriminante nell’associare la Fotografia alla pittura e che pone quest’ultima sempre al di sopra di quella che rimane così una sua povera ancella. La composizione implica, come abbiamo visto nella foto di Rosenthal, un intervento progettuale. Si definisce Composizione ogni creazione che traduce un atto rappresentativo: composizione musicale, composizione letteraria, composizione architettonica, ecc.
La parola composizione è sinonimo di qualità artistica. Anche in fotografia utilizziamo lo stesso termine per valutare l’aspetto esteriore di una immagine: una foto è bella se ha una composizione equilibrata, cioè se le linee di forza, l’equilibrio delle masse, il rapporto tra i colori e la posizione delle luci rispondono agli stessi criteri con cui osserveremmo un dipinto figurativo. Spesso si utilizzano definizioni fin troppo succubi alla pittura: ammiriamo «l’illuminazione caravaggesca» in una foto di studio e il «triangolo di Rembrandt» in un ritratto posato. Per carità, se questi elementi compositivi sono voluti e provengono da una precisa volontà di citazione da parte del fotografo a specifiche opere di Caravaggio o di Rembrandt mi possono stare benissimo. Ma se utilizziamo genericamente locuzioni come queste, se ricorriamo a parametri di osservazione derivati dalla pittura quando siamo davanti a una fotografia, allora stiamo mortificando la Fotografia.
I maggiori colpevoli di questa limitazione all’autonomia del medium fotografico sono, ovviamente, gli stessi fotografi che adottano quegli elementi compositivi per raggiungere quella qualità esteriore che aspira a far tendere verso l’artisticità la loro creazione fotografica; in realtà, come sostiene Marra – appoggiandosi alle parole di Susan Sontag – proprio «quei fotografi che si sforzarono di combattere l’apparente realismo superficiale del mezzo (fotografico) furono quelli che ne trasmisero in maniera più limitata le proprietà». Come dire che più ci si sforza di aderire esteriormente allo stile di una determinata corrente artistica, più ci si allontana dal Pensiero che la sottende, rinunciando a elaborare una estetica che sia autonomamente fotografica.
Lo dichiara implicitamente anche l’amico Guido Cecere, curatore della mostra, nel descrivere una foto di Nino Migliori raffigurante un muro incrostato di manifesti strappati: «sembra un quadro di Alberto Burri»; e lo stesso Migliori, quasi a giustificarsi, afferma (ancora citato nel libro di Marra) «A quei tempi non conoscevo, dico nel 1948 fino al 1953 circa, nulla di pittura né americana né europea», intendendo così rivendicare l’originalità della sua ricerca rispetto alla pittura. Ma in ogni caso individua in essa il suo termine di confronto.

Ci sono un paio di aspetti però di quella foto, apparentemente contraddittori, che giudico più propriamente indirizzati alla specificità medium fotografico: la scelta di stampare la foto in dimensioni tali da renderla approssimativamente in scala uno a uno rispetto al soggetto originale e il montaggio su un pannello sabbiato che restituisce la matericità del muro. In questi due elementi trovo sia la ripetibilità dell’opera, propria della fotografia, che l’intento di prelievo di una parte della realtà fisica osservata.
Questo secondo aspetto lo considero di primaria importanza perché, insieme all’errore meccanico, è quello che distingue la Fotografia da ogni altro sistema espressivo, quello che maggiormente la distingue dalla pittura e da ogni altra forma d’arte.
Lo specifico fotografico consiste proprio nel prelievo di una parte della realtà fisica: Marra insiste proprio su questo concetto sottolineando come l’adesione della Fotografia alla contemporaneità artistica debba essere ricercata più sulla condivisione del Pensiero che sulla concordanza delle forme; oserei dire che anche molta critica, parlando di fotografia, spesso ha confuso il Linguaggio, cioè la struttura concettuale, con il Lessico, ossia con l’insieme di forme attraverso le quali quel pensiero si è manifestato nei diversi media, comparando in questa operazione solo l’aspetto esteriore della pittura e della fotografia.
Dai fotografi viene vissuta molto male la condizione di mancato riconoscimento, alla Fotografia, di essere un Linguaggio, quasi che la dichiarazione di impossibilità a divenire “rappresentazione”, cioè di essere priva di valore simbolico, neghi la capaciità di essere considerata Arte. Eppure, a partire da Man Ray che della fotografia fece un grande uso artistico, è proprio la facoltà di essere semplice indice che la rende diversa da tutti gli altri sistemi espressivi. Ciò che rimane imprigionato dentro al fotogramma presenta null’altro che sé stesso, però estrapolato, prelevato, da tutto quanto lo circonda e proprio questa operazione di straniamento ci permette di elevare il soggetto a un piano superiore rispetto alla realtà fisica: chiamiamolo pure piano super-reale o anche meta-fisico.
La Natura, il mondo, gli eventi chiusi dentro al fotogramma sono scavati, estratti, vivono di vita propria senza bisogno di contesto. Atget fotografa le fontane, i portoni, i vicoli di Parigi in modo quasi compulsivo; oggi potremmo venire confusi da chi dice che quelle foto sono “solo” documenti: eventualmente possono essere utilizzate “anche” come documento, ma tutti quei soggetti fotografati hanno il sapore del Object-trouvé che ha la propria ragione nel fatto di essere esistito, e di esistere ancora, in quanto immagine fotografica. Lo stesso Walker Evans mette i giusti paletti tra ciò che è documento e lo Stile documentario che ha valenza artistica: «Un esempio di documento in senso letterale sarebbe la fotografia di un crimine scattata dalla polizia. Un documento ha una utilità mentre l’arte è davvero inutile. Perciò l’arte non è mai un documento anche se può adottarne lo stile».
Nelle parole di Walker Evans si riconosce ancora un modo di individuare la specificità fotografica come semplice operazione di prelievo di un brano della realtà fisica secondo regole che escludono la composizione, ma che implicano una capacità di osservazione da parte del fotografo che di per sé diviene già atto creativo.
L’atto di osservare, piuttosto che di comporre, è ciò che caratterizza il fotografo anche secondo Luigi Ghirri che invita a «cercare nella realtà le inquadrature che già esistono» non senza l’introduzione di precise regole che devono guidare non tanto l’individuazione del soggetto quanto la scelta del miglior punto di osservazione – che definisce soglia –, il più idoneo punto da cui prelevare quella determinata immagine affinché risulti comunicabile uscendo dal mondo fisico per elevarsi al piano meta-fisico. Il valore metafisico di quanto prelevato dentro il fotogramma è implicito nelle parole di Ghirri che sottolinea l’importanza del processo mentale nella scelta dello scatto: «il problema è capire come ritagliamo queste finestre mentali, queste finestre che sono nella realtà e che ritroviamo mentalmente quando andiamo a fotografare» individuando «un confine tra quello che pensiamo, quello che vediamo, quello che possiamo vedere, quello che dobbiamo vedere […] Si tratta di attivare un processo mentale, di attivare lo sguardo e cominciare a scoprire nella realtà cose che prima non vedevamo».

Queste ultime parole, che richiamano la necessità di estraniarsi in modo da poter osservare il mondo liberi da qualsiasi sovrastruttura, sembrano parafrasare quanto scrive De Chirico: «ma ammettiamo che per un momento […] si spezzi il filo di quella collana (dei ricordi) chissà come vedrei… […] La scena però non sarebbe cambiata, sono io che la vedrei sotto un altro angolo. Eccoci all’aspetto metafisico delle cose».
Prelevare all’interno della finestra fotografica un brano della realtà fisica, accuratamente scelto attraverso l’esercizio dell’osservazione asettica e documentaria, per elevarlo ad una realtà superiore sembra così essere lo specifico del medium fotografico.
Esattamente il contrario di quanto avviene nella pittura che è l’inserimento di un mondo finzionale, rappresentativo, narrativo o simbolico, che esaurisce il proprio signficato all’interno di una cornice albertiana.
Per dirla banalmente, la fotografia estrae, la pittura inserisce.
Quest’ultima, forzata, sintesi mi ricorda l’avversione che Michelangelo provava nei confronti della pittura, lui pittore eccelso che però si considerava scultore. La pittura, sosteneva, (ma anche l’architettura, la scrittura, la musica…) si fanno attraverso l’aggiunta di materia (di segni, note e lettere…) e di significati, mentre la scultura si fa «per il togliere» cioè rimuovendo quella materia informe che imprigiona la Vita all’interno di una Natura amorfa, vita che aspetta solo di essere liberata dall’artista.
Liberare ciò che è imprigionato nella massa di forme indistinte, portarlo alla luce, è una operazione molto simile all’esercizio dello sguardo che induce il fotografo a prelevare il soggetto da innalzare al di sopra del piano meramente fisico.
Forse non è poi così stupido associare la Fotografia alla Scultura.
E poi anche Dio è stato scultore, no?
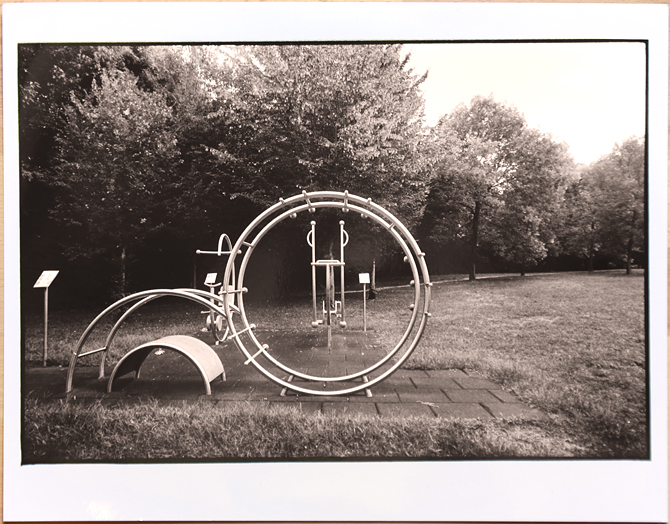

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.