La verità, ammettiamolo, è che noi fotografi abbiamo un grandissimo complesso di inferiorità nei confronti delle altra arti applicate, e della pittura in particolare: noi fotografi abbiamo una sorta di complesso del pennello piccolo; oggi si usa spesso la definizione fine art per descrivere quelle immagini che si vogliono elevare al di sopra delle comuni fotografie, quelle che si producono a milioni ogni giorno – anche con gli smartphones – in vacanza o nella quotidianità e che hanno per soggetti i figli o la fidanzata, il proprio gatto o l’ultimo bel tramonto inquadrato dalla finestra della cucina.
Sono queste, forse, meno fotografie di quelle definite fine art? Qualcuno tende a spostare la risposta sullo statuto dell’operatore, del fotografo insomma: chi non è Fotografo, definito per professione o attività, non produce Fotografie, ma solo immagini. Non mi risulta che la definizione “immagine” costituisca una categoria inferiore rispetto a “fotografia”; anche un dipinto di Millet è immagine. Perciò risolvere la questione in base al mestiere svolto dall’operatore, arrivando anche a distinguere se ha impugnato una vera macchina fotografica o un telefono cellulare dotato di fotocamera, è solo una falsa e illusoria risposta al problema.

Perché non partire, allora, dall’utilità – o dall’utilizzo – che quella fotografia ha? La mia amica Giulia trova certamente più utile, più significante, la foto ricordo scattata in vacanza sulle scogliere di Scala dei Turchi che una veduta urbana di Andreas Gursky, benché valutata decine di migliaia di euro. Si tratta, insomma, dall’assegnare valori diversi a cose diverse. Non esiste più LA Fotografia, ma un insieme di linguaggi e utilizzi diversi per il prodotto/risultato di un unico strumento tecnico (la macchina fotografica), all’interno di un grande, e in continua espansione, Sistema Espressivo.
Sbaglia, a mio avviso, anche chi continua a dire che la “fotografia è un linguaggio”: è evidente che la fotografia di moda e la fotografia sportiva comunicano in modi e forme semantiche diverse, visto che hanno utilizzi diversi; perciò dire che “la fotografia è un linguaggio” equivale ad affermare che “la scrittura è un linguaggio”, si confonde così il mezzo (medium) espressivo col suo utilizzo comunicativo. Cosa ancora diversa è lo “strumento”, cioè la matita o la stilografica per la scrittura, il pennello o la spatola per la pittura, il pianoforte o il violino per la musica, la medio formato a pellicola o lo smartphone digitale per la fotografia.
La scrittura – a cui sempre fanno riferimento i semiologi anche parlando di fotografia – nei suoi oltre cinquemila anni di storia, ha saputo differenziarsi in generi, stili e utilizzi, tutti che utilizzano lo stesso Sistema Espressivo di segni (alfabetici) e di convenzioni grammaticali: romanzo, novella, poema, sonetto… contratto, articolo di cronaca, email, SMS… ognuno nel tempo ha costruito il proprio linguaggio, definito nella sua struttura narrativa; di conseguenza la definizione “scrittore”, inteso comunque colui che scrive (con la penna d’oca o col computer non è rilevante), è divenuta insufficiente per indicare il genere letterario e il linguaggio a questo compatibile: così ora distinguiamo il saggista, il romanziere, il notaio, la blogger, la fidanzata… tutti usano allo stesso modo la scrittura, ma nel tempo sono stati individuati scopi e utilizzi diversificati. Possiamo comprendere allora che il termine “fotografo”, perché non ce ne sono altri per definire chi fotografa, oggi appare assolutamente limitativo e inadeguato. Inutile ai fini della definizione del ruolo della Fotografia, e dei mutamenti in atto al suo interno, nella società che la utilizza. La Fotografia ha solo un secolo e mezzo di storia, è solo una bimba che sta imparando a camminare e sbatte sugli spigoli del contesto in cui sta imparando a muoversi. I tempi futuri permetteranno di distinguere utilizzi e definizioni che ora sono descritti in modo confuso dalle parole “fotografia” e “fotografo”.
Intendere la fotografia come espressione artistica non può che aggiungere nuova confusione a quella già grande che la circonda. Il recente, per l’Italia, conio verbale “fine art” – “arte applicata” – non si capisce se è riferito a un genere fotografico diverso ed elevato (nudo, paesaggio, elaborazione grafica) da quello quotidiano, o alla sua materialità (un tipo di stampa artigianale o di durata garantita nel tempo) o, ancora, alla sua destinazione (collezionismo, esposizione); ma questo equivoco accade perché, ancora una volta, non si definisce chi è l’attante che la pratica e la sua finalità.
L’attante (termine equivalente ad attore, inteso come colui che compie una azione) non è una persona: è il risultato di una trasformazione che la macchina induce su chi la usa; per capirci, questa definizione introduce la distanza che ci può essere tra un automobilista ed un pilota: dipende dall’auto che è abilitato a guidare in un preciso contesto (la strada o la pista) e così torniamo al fatto che, per il termine fotografo, una simile coppia di termini che marchi la distinzione tra “chi fotografa cosa e per quale scopo” ancora manca.
L’uomo munito di macchina fotografica è un essere diverso, cibernetico, dotato di una protesi meccanica che fa di lui un essere nuovo; non semplicemente diverso in modo generico: questo cyborg si trasforma a seconda dell’apparecchio fotografico che impugna. «Il fotografo non è semplicemente una persona che ha con sé un apparecchio, è un soggetto nuovo, trasformato nella sua fisicità e dunque nella sua soggettività, con tutto ciò che questo comporta» scrive Dario Mangano (Cos’è la semiotica della fotografia, pag. 15) ne consegue che la stessa percezione della realtà che ci circonda è condizionata dalla macchina fotografica che impugniamo come una protesi visiva e mnemonica: «chi va alla festa del paese con la sua reflex al collo starà tutto il tempo in tensione, pronto a entrare in azione, sgomitando fino al cuore della processione perché è lì che l’immagine che cerca può manifestarsi e lui deve essere pronto a coglierla. Se, invece, porta con sé soltanto un cellulare, sebbene in grado di esprimere una qualità tecnica anche notevole, non avrà la stessa disposizione, non sarà lo stesso attante» (ibidem, pag 19). Come a dire che chi va ad una processione tradizionale siciliana munito di reflex e grandangolo sa già quali foto cercare, anche perché le ha già viste; e sceglie come prolunga del proprio occhio il tipo di macchina più idonea per ottenerle, proprio quella che è stata costruita apposta per quel tipo di foto. E saranno sicuramente belle foto, perché la sua attrezzatura è stata pensata e costruita appositamente per quel risultato.
«La percezione fotografica di chi scatta è socialmente costruita» afferma ancora Mangano (pag. 17) ed in questo è pienamente in linea con ciò che Franco Vaccari, in tempi non sospetti, battezzava come inconscio tecnologico.
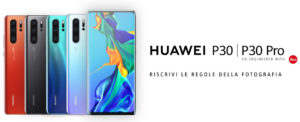
I costruttori di oggetti tecnologici sono bravi a inventare bisogni che fino a quel momento non erano sentiti, bisogni soddisfatti da prodotti che tempestivamente saranno introdotti nel mercato; questa logica non deve essere interpretata banalmente in senso negativo perché sta alla base dell’idea stessa di progresso: come possiamo oggi rinunciare alla lavatrice, al televisore, al cellulare? Quindi l’intervento dell’inconscio tecnlogico non sta tanto nella soddisfazione di un nuovo bisogno, quanto nella impellente necessità del suo continuo adeguamento ad uno status sociale, ad una moda, nell’aggiunta di una funzione complementare già soddisfatta da altri prodotti (come è la fotocamera per il cellulare) e, soprattutto, nel darci l’illusione di avere il totale controllo di quello strumento, cioè nel farci credere di non essere diventati suoi schiavi: quando i produttori ci dicono che quell’apparecchio “è facile da usare” non significa che possiamo averne facilmente il controllo totale, al contrario nascondono il fatto che la maggior parte delle funzioni complesse vengono svolte indipendentemente dalla nostra volontà, a nostra insaputa, semplicemente perché quella macchina è stata progettata per soddisfarci. All’interno di ogni macchina, perciò, esiste una forma di pensiero decisionale che non è il nostro, ma quello dei progettisti che si sono fatti interpreti di un bisogno sociale che agisce in modo orizzontale, profondo, fuori dal nostro controllo: una forma di inconscio collettivo che è insito nella macchina e lavora attraverso la tecnologia.
La prova? Scattate una foto alla vostra fidanzata, oppure un bel paesaggio al tramonto con un cellulare e contemporaneamente con una sofisticata reflex, magari anche in formato raw; quale delle due soddisferà maggiormente il vostro desiderio di aver realizzato una bella foto? Sicuramente quella fatta col cellulare perché la fotocamera di cui è dotato è stata progettata per rendere al meglio proprio quei soggetti, perché si avvicina di più al senso della nostra visione immediata; al contrario quella scattata con la reflex non avrà la stessa vivacità di colori perché avrà registrato anche quei colori che il nostro occhio non è stato in grado di registrare e il nostro cervello non avrà elaborato come “colori tipici di un tramonto” sulla base di stereotipi che influenzano i nostri sensi. Nella fotocamera di un cellulare il livello di inconscio tecnologico è elevatissimo, tant’è che rincorriamo quelli ultimo modello perché sono quelli che fanno le foto sempre più belle.
Dal lato opposto, anche le reflex digitali più sofisticate non sono meno “colpevoli”. Quante regolazioni avevano le vecchie reflex analogiche, quelle manuali che consentivano la massima autonomia decisionale? Tre: tempo, diaframma, ASA. Quante bastavano per scattare una fotografia. Oggi non ho idea di quante siano le opzioni, le regolazioni, gli aggiustamenti che sono impilate nei menu della mia ultima digitale. MI sono sempre rifiutato di esplorarle e di leggere il manuale d’uso, ma sono sicuramente decine. Servono? Servono, come i programmi di lavaggio in una lavatrice, per credere di ottenere un risultato migliore; ma l’acqua e il detergente, lo strofinio e il risciacquo sono sempre gli stessi, irrinunciabili nella lavatrice come lo sono i rapporti tempo/diaframma/sensibilità in una fotocamera.
Anche in questo caso perciò possiamo dire che tutte quelle regolazioni coerentemente impachettate nei menu richiamabili sul display non sono altro che una forma di inconscio tecnologico di cui si nutrono i fotografi, quelli più progrediti rispetto a quelli che usano il cellulare, quelli che conoscono ogni postilla del manuale e che confrontano sui blog le prestazioni di ogni nuovo prodotto immesso sul mercato.
Questi ultimi, quelli che credono di avere il maggiore controllo sulla macchina (fotografica) sono le vittime più ingenue e meno consapevoli di essere vittime dell’inconscio tecnologico.
Tornando alle considerazioni iniziali relative all’artisticità della fotografia, proprio perché si illudono di poter dominare la macchina, questi fotografi sono quelli che tendono a ridurre, fino ad annullarlo, il suo contributo nella produzione delle loro fotografie, sono quelli che pretendono di proporre la propria visione autoriale, sono quelli che affermano «la fotografia è un’arte» …e che di conseguenza aspirano a essere considerati artisti.
«…nell’intervento umano, teso ad attribuire all’immagine un valore significativo ed espressivo, non vediamo che un fraintendimento della fotografia, una rimozione della sua realtà più profonda. Il fotografo, strutturando l’immagine secondo le proprie convinzioni estetiche e vivendole come oggettive, si perde in una situazione tautologica dove non incontra altro che le proprie proiezioni» (Franco Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, pag. 13); la pretesa di intervento autoriale produce una «fotografia surcodificata che ha sempre qualcosa di isterico, in essa il vero significato (di cui il fotografo è spesso inconsapevole, n.d.r.) viene rimosso e ricoperto da significati di copertura (…) il suo valore collettivo viene così compromesso ed esso diventa espressione dell’immaginario individuale». «Queste immagini sono sempre accompagnate da un ammiccare continuo che allude all’autocompiacimento per l’esercizio acrobatico ben riuscito, ma in realtà senza alcun rischio perché ottenuto attraverso tecniche già collaudate e di sicuro effetto». (ibidem, pagg. 21 e 22).
L’autorialità sfoggiata da molti fotografi non risulta mai priva di retorica, cioè di adesione a linguaggi e strutture estetiche elevate, certificate e di universale gradimento, anche quando non cade volontariamente nel pittorialismo di genere e nel poetico: scrive ancora Vaccari «la fotografia diventa così una delle tante manifestazioni della cattiva pittura» (pag. 44).
Oltre al narcisismo del fotografo, cosa riescono a comunicare queste fotografie? Qual è il loro significato? Cercate in rete su Flikr o su Deviantart due fotografie artistiche realizzate rispettivamente nel 2005 e nel 2019, quali significati riusciamo a cogliere? Se le due fotografie sono analoghe (due ritratti, due paesaggi…) probabilmente rileveremo un messaggio analogo e lo stesso intento di realizzare una bella foto. Non troveremo nulla di nuovo, a parte l’influenza di alcune mode, in quelle foto. Ma c’è un messaggio molto meno evidente e più profondo che rischia di sfuggirci ed è quello determinato proprio dall’intervento dell’inconscio tecnologico: ci accorgeremo che l’evoluzione dei software di fotoritocco è stata impressionante, che la possibilità di eseguire fotomontaggi è diventata alla portata di tutti, che i computer hanno raggiunto potenze di calcolo inimmaginabili solo quindici anni fa. Avremo una proiezione dell’evoluzione tecnologica della nostra società, e questa analisi sarà l’unico valore riscontrabile in quelle immagini.
E adesso? Dite che vi ho fatto venire voglia di smettere di fotografare? Spero di no, perciò riassumo: smettete di cercare di fare foto belle, le belle foto sono inutili; invece fate foto utili: utili per voi e per gli altri.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.